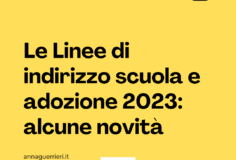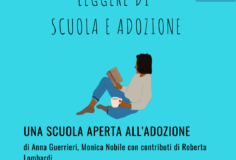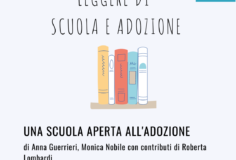Riconoscersi in un figlio adolescente significa guardarsi negli occhi di una persona in rapido cambiamento. E’ il momento in cui il tempo dei genitori e il tempo dei figli non è più accordato dallo stesso diapason: gli uni dentro al presente, gli altri tra un passato ormai ampio e un futuro di cui si inizia a scorgere (e temere) il limite. L’adolescenza dei figli sorprende, risveglia all’improvviso. I figli si trasformano, il loro corpo, bruscamente ben oltre i contorni dell’infanzia, si amplifica e risplende anche nelle disarmonie, mentre quello dei genitori, nonostante gli sforzi, si contrae, invecchia.
Quello che passa nella loro mente e nei loro cuori appare in lontananza. Sono così evidenti e plateali nelle richieste, urgenti, e al tempo stessi trasversali e abilmente nascosti nel tentativo (spesso efficacissimo) di non essere troppo visibili agli occhi indagatori (e possessivi) degli adulti. Escono, entrano, scompaiono nella propria stanza, sfuggono veloci fuori casa e nei propri mondi, costantemente in connessione con qualcun altro, eternamente altrove, sempre più rapidi nel saper come comunicare senza essere intercettati, un passo avanti nella criptazione dei loro messaggi, tecnologicamente ben oltre le sperimentazioni adulte.
Assomigliarsi e ritrovarsi, allora, significa farlo in corsa assistendo ad una trasformazione che si riconosce solo se la si riesce a ricordare, ad ammettere che la si è già vissuta. Un tempo anche i loro genitori sono stati esattamente così, rapidi e scomposti, assorti ed estroversi, arrabbiati e innamorati, impauriti e desiderosi. Anche loro un tempo avevano la stessa pelle, lo stesso corpo irriconoscibile, lo stesso sguardo, il medesimo ritmo. Rispecchiarsi significa nonostante le contraddizioni, le contestazioni, o forse proprio grazie a tutto questo.
E quando non ci si riconosce completamente? Quando non si hanno lo stesso corpo, la stessa voce, lo stesso sguardo come accade nell’adozione? Quando una trasformazione vorticosa non corrisponde affatto e non si riconosce né quella pelle lucente, né quelle capacità improvvise, né quelle difficoltà e crisi che non si sono avute? Quando anzi tutto questo corrisponde a qualcun altro che non si si è mai incontrato? Quando tutto è accaduto tutto troppo in fretta con un figlio che non è mai stato dentro abbastanza o magari è arrivato solo pochi (troppo pochi) anni fa? Come trovare spazio in quegli occhi che contengono altri occhi, altri orizzonti?
I ragazzi a volte diventano incomprensibili, indecifrabili e, talvolta, fanno paura. Si temono le reazioni spropositate, gli scoppi d’ira, le opposizioni che davvero accadono, che davvero spiazzano e distruggono. Non si riesce a sentire di poter mediare, contenere, fermare. E non ci sono fermate in effetti. Si può realmente avvertire il pericolo di non avere il potere di “farci nulla”, di non potere affrontare qualcosa che viene da “fuori”, come se si avesse a che fare con un’estraneità che non si conosce, comprende e accetta e quindi risulta ingestibile. Se non dipende da “noi stessi” e dalla “nostra famiglia”, se non ha a che fare con “noi genitori”, è legittimo chiedersi come sia possibile appartenersi e recuperarsi.
Si appartiene mai in adozione e a chi? E’ possibile che alla prova dei rapidi cambiamenti, legami troppo incerti, si spezzino? E’ possibile avere così tanta paura di un figlio da temere di averlo nella propria casa?
La famiglia adottiva è una famiglia affollata, poliedrica, piena di troppe dichiarazioni ufficiali e di segreti ben tenuti dove il paradigma dell’amore che accoglie e trasforma è una sorta di maschera da indossare. E si finisce poi per indossarla con troppa serietà, l’interpretazione della famiglia adottiva perfetta. I sentimenti veri sono difficili da esprimere a volte, i desideri profondi di unità, le paure di non riuscire a raggiungersi, di non sapersi realmente. Il timore di perdersi, di non riuscire a costruire un “noi” reale e duraturo, di avere un legame a tempo o frangibile davanti alla potenza di un’alterità che non si riesce a controllare, sono fin troppo negati, ma sono lì, pronti ad emergere quando i figli distruggono facciate meticolosamente costruite.
Rubare, spacciare, spaccare, fuggire, farsi e fare del male demoliscono inesorabilmente l’immagine che si voleva dare di se e della propria famiglia. E diventa facile pensare che dipenda tutto da una dimensione adottiva eternamente condannata alla mancanza e all’insoddisfazione. Sembra quasi che l’adozione autorizzi a pensare che il danno sia proprietà esclusiva dei figli, e il paradigma troppo facilmente si trasforma da quello della “famiglia perfetta” a quello della “famiglia eroica”. Qualcosa va storto a volte ed anche molto. Il problema tuttavia non è solamente ciò che accade ma come in famiglia ciò che accade può venire elaborato.
E’ possibile tenere dentro quel che capita? Il rifiuto dei figli, la loro aggressività, trasgressività, il loro dolore? E’ sempre possibile vedere come noi reagiamo realmente e che parte abbiamo in tutto quello vorremmo non accadesse? E quando si è in grave difficoltà, come e dove cercare un aiuto? Come continuare a credere di poter essere famiglie?
Abbandonandosi alla sensazione dell’appartenenza si avverte che possa significare credere fermamente di potersi ritrovare l’uno nell’altro, anche quando si è lontani. Sentire di avere la possibilità di potersi toccare in profondità, partecipi di una zona condivisa dove si entra assieme e dove si può stare spogliati del resto, capaci di guardarsi per chi si è, non più intralciati da un altrove sconosciuto, solo presenti in quell’istante così breve in cui ci si ferma e ci si vede, non più in corsa anche per un solo istante. Allora si è semplicemente ciò che si è e si ha la possibilità di riconoscersi in un’umanità che non ha bisogno di definizioni di alcun tipo. E’ la zona che si ricerca e si trova senza mappe, che non si insegna, cui non si conduce, è interiore e non possono altri costruirla al nostro posto. Lì ci si sfiora nell’emozione, ma a volte anche nello sconcerto o nella fatica. E’ solo una zona autentica, dove si è come si è.
Lì forse si possono intercettare figli in fuga e dire che si è umani come loro e si è qui. Anche i genitori hanno amato e odiato, hanno avuto paura e tanta, anche loro hanno subìto gli adulti, le loro aspettative, le loro contraddizioni, il loro amore invadente, la loro malvagità (a volte), anche loro volevano fuggire e volevano tornare. Erano come sono loro adesso, senza che nessuna differenza, di storia, di pelle, di taglio d’occhi, possa metterlo in discussione. Sono stati anche loro ragazzi e non sapevano cosa erano la morte e il tempo e il limite. Credevano di poter conquistare il loro mondo e di sfidarlo. Vivevano anche loro attraverso i propri amici, con loro, per loro, malgrado loro e usavano in modo differente dai propri genitori ogni tecnologia. E sognavano come i figli ora sognano. Avevano valori ed erano importanti e urgenti come ora, oggi, quelli dei figli sono.
Travalicare le differenze, smettere di avere paura, potrebbe passare attraverso l’accettarsi umani e fallibili e imperfetti. I genitori come i figli, bellissimi entrambi nonostante i tempi diversi e le differenti età. Forse attraverso questo reciproco riconoscimento di umanità c’è davvero la possibilità di vedersi, e allora sì di riconoscersi, di darsi reciprocamente qualcosa che può durare. Ed è questo poco descrivibile “qualcosa” che potrebbe venire in soccorso nei momenti di maggiore disperazione, un serbatoio di contatto cui attingere, cui ricorrere per ricordare chi veramente si è, per non perdersi di vista anche quando si è in distanza.
La dimensione adottiva è allora solo una risorsa in più, non più rinchiusa dalle parole proprie del danno e del trauma, permettendo di pensare al vero significato di appartenenza, non per nascita, non per sangue, non per somiglianza ma per incontro.
Last modified: 27 Giugno 2021